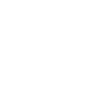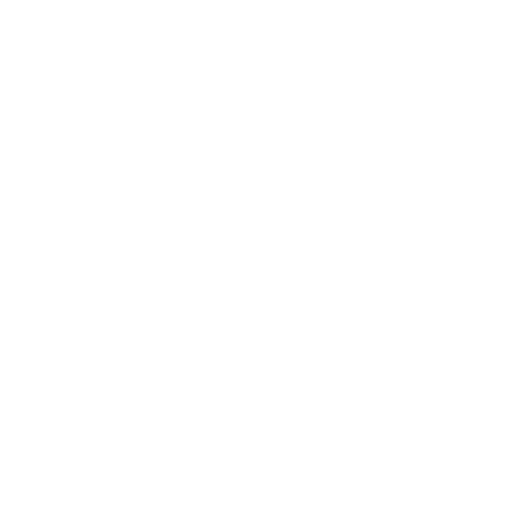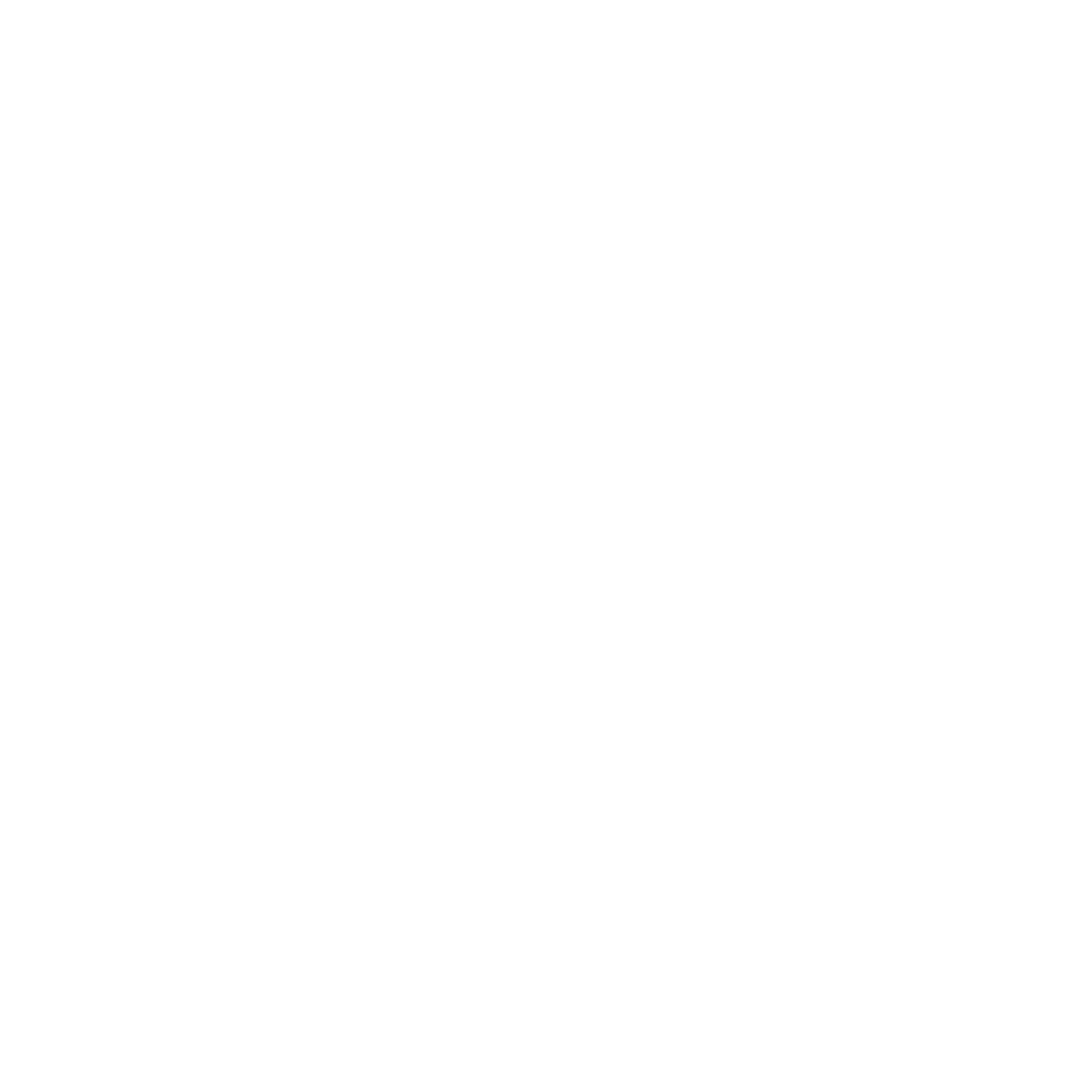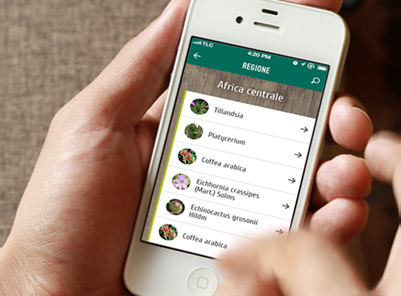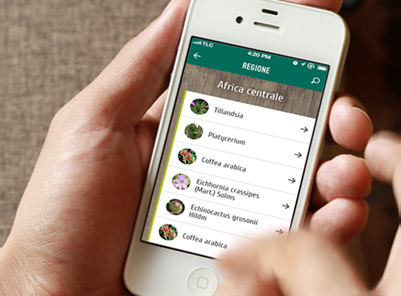You can visit the Old Garden, the 19th-century greenhouses, the arboretum, and the Botanical Museum
Find out more
An integrated ticket to visit the Botanical Garden, Palazzo del Bo and the new Museum of Nature and Humankind
Find out more
The new restoration project involve the central fountain, the fountains of the quarters, of Theophrastus and of the Four Seasons
Find out moreSpecie botaniche
-
 Philodendron bipinnatifidum
Philodendron bipinnatifidum
Arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Araceae, è originario del Sud America e, più specificatamente, delle foreste pluviali brasiliane ma viene ampiamente coltivato lungo le coste americane così come in alcune zone dell’Asia quali le Filippine.
Il fusto, che può superare i tre metri d’altezza, è a rapida crescita e spesso produce lunghe radici aeree vicino alla base, dalle quali è derivato uno dei nomi vernacolari di questa specie (fillodendro àncora). Le foglie sono grandi, arrivano tranquillamente al metro di lunghezza, profondamente incise e simili a quelle di Monstera deliciosa Liebm., specie della stessa famiglia e originaria nell’America centrale. L’infiorescenza, che si sviluppa tardivamente, consiste in un lungo spadice bianco-verde parzialmente avvolto da una spata verde esteriormente e color crema all’interno; sullo spadice sono presenti migliaia di piccoli fiori con i maschili concentrati all’apice, i femminili alla base e una serie di fiori maschili sterili nella parte centrale. Con l’inizio della fioritura si sviluppano, all’interno della spata, temperature piuttosto elevate che, unitamente all’odore, attirano gli impollinatori, principalmente alcuni coleotteri notturni.
La specie contiene delle sostanze tossiche, soprattutto ossalati di calcio, che la rendono dannosa sia per ingestione che per contatto.
-
 Myrtus communis
Myrtus communis
Il mirto, presente allo stato spontaneo nella macchia mediterranea, è spesso coltivato come pianta ornamentale in parchi e giardini, da cui a volte sfugge soprattutto nell'Italia mediterranea. Il nome generico deriva da ‘mýrtos’, quello greco della pianta, e questo forse deriva da ‘mýro’ (io stillo); è legato a quello di Myrsine, leggendaria fanciulla greca uccisa da un giovane da lei battuto nei giochi ginnici e trasformata da Pallade in un arbusto di mirto. Periodo di fioritura: giugno-luglio.
-
 Vitis vinifera
Vitis vinifera
La vite è una liana decidua tipicamente mediterranea, oggi coltivata in tutte le aree del globo con clima di tipo mediterraneo (California, Cile Centrale, Sudafrica, Australia meridionale). I primi riferimenti storici alla vite e al vino si trovano tra i Sumeri nell'Epopea di Gilgamesh (III millennio a.C.); testimonianze della coltura si hanno in numerosi geroglifici egizi, presso i quali il vino era bevanda riservata ai sacerdoti, agli alti funzionari e ai re. Furono i Greci ad introdurre la vitivinicoltura in Europa, già in epoca minoica. Esiodo descrive in dettaglio pratiche di vendemmia e di vinificazione e numerosi sono i riferimenti alla vite e al vino anche in Omero. Ai coloni greci si deve l’introduzione della viticoltura in Italia meridionale, dove la pianta incontrò condizioni climatiche e pedologiche ideali, al punto da far meritare alla regione il nome di Enotria. Studi paleontologici hanno però dimostrato che la pianta della vite era già diffusa in Italia, in particolare in Toscana, dove esisteva prima della comparsa degli etruschi. I Romani perfezionarono ulteriormente le tecniche vitivinicole apprese dagli etruschi, come illustrato da numerose opere, in cui si ritrovano concetti biologici e tecniche di coltura tuttora validi. Nel XIX secolo due malattie fungine e un insetto provenienti dall'America sconvolgono la vite: la peronospora della vite, l'oidio e la fillossera, che distrussero vaste estensioni di vigneti tra il 1870 e il 1950. I coltivatori furono costretti a innestare i vitigni sopravvissuti su specie (e ibridi) di origine americana (Vitis berlandieri, V. rupestris e V. riparia), resistenti alla fillossera, e a utilizzare regolarmente prodotti fitosanitari come lo zolfo e il rame per contrastare l'oidio e la peronospora. A volte la vite appare anche allo stato subspontaneo, in arbusteti e siepi presso gli abitati rurali ed in vegetazioni ruderali, su suoli limoso-argillosi mediamente profondi, neutro-subacidi, ricchi in composti azotati. Il nome generico è il nome latino della vite, che deriva da 'viere' (legare), in riferimento alla flessibilità dei rami; il nome specifico si riferisce alla coltivazione per produrre il vino. Forma biologica: fanerofita lianosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.
-
 Viburnum opulus
Viburnum opulus
Il viburno palla di neve è un albero spontaneo in Europa, Asia e Africa nord-occidentale, presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Puglia, Calabria e forse Valle d'Aosta, ma più diffuso nelle regioni settentrionali. Cresce in boschi umidi alveali, pioppete, siepi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore. È una pianta rustica e facile da coltivare, molto utilizzata per la formazione di siepi in interventi di rinaturalizzazione e per scopi ornamentali; in questo caso è ampiamente coltivata la cultivar 'roseum', con infiorescenze globose costituite interamente da fiori sterili. Tutte le parti della pianta, compresi i frutti, sono tossiche. Il nome del genere è molto antico e di etimologia incerta: potrebbe derivare dal latino 'viere' (legare, intrecciare), con allusione alla flessibilità dei rami di alcune specie, utilizzati un tempo per costruire ceste, oppure da 'vovorna' (dei luoghi selvatici); il nome specifico era utilizzato dai Romani per indicare un acero, probabilmente l'acero campestre, localmente chiamato tuttora 'opi', e si riferisce alla somiglianza delle foglie lobate con quelle dell'acero. Forma biologica: fanerofita cespugliosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
-
 Casimiroa edulis
Casimiroa edulis
Chiamata comunemente col nome di sapote bianco, Casimiroa edulis è una specie sempreverde originaria del Messico, Guatemala e limitrofi, che appartiene alla stessa famiglia del limone. E’ un albero a rapida crescita, che può raggiungere i 18 m di altezza, con corteccia verde grigiastra con lenticelle. Le foglie sono palmate, composte da 3-7 foglioline ovali ad apice acuto, da giovani di color rosso rame, poi verde scuro. In primavera la pianta produce fiori in grappoli, verdi-giallastri, poco vistosi e inodori. I frutti sono drupe di forma sferica che possono arrivare a 10 cm di diametro, sono giallo verdognole dal sapore ottimo.
La buccia sottile racchiude una polpa bianca di consistenza burrosa, ricca di vitamina A e C e particolarmente dolce, in quanto contiene oltre il 26% di zuccheri. Il frutto contiene fino a 5 semi, di aspetto simile a quelli del limone, ma di dimensioni molto maggiori, duri, amari e non commestibili. Corteccia, foglie e semi contengono molti metaboliti, fra cui la zapotina e la casimiroina.
Il sapote era noto alle civiltà precolombiane che ne utilizzavano i frutti commestibili e per le proprietà ipnotiche e allucinogene della farina ricavata dai semi. Infatti il nome nell’antica lingua indigena messicana nahuatl significa “zapote del sonno”. Il tè preparato con le foglie veniva usato per stimolare le visioni oniriche. Recenti studi hanno confermato le proprietà antinfiammatorie, antipertensive e sedative della pianta.
-
 Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Il barbone adriatico è un’orchidea a distribuzione eurimediterraneo orientale (Italia e Penisola Balcanica) presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Valle d’Aosta e in Puglia. La distribuzione regionale si concentra nella parte sudorientale del territorio; in Carso la specie è localizzata sul M. Sabotino e nei dintorni di Trieste. Cresce negli orli di boschi termofili di latifoglie decidue e in prati submesofili, su suoli argillosi abbastanza profondi, ricchi in basi ma talvolta decalcificati, da neutri a subacidi, al di sotto della fascia montana inferiore. Il nome generico deriva dal greco 'himántos' (striscia di cuoio), e 'glossa' (lingua), per il lunghissimo labello nastriforme; il nome specifico si riferisce alla distribuzione centrata sulle regioni situate attorno al Mare Adriatico. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.
-
 Humulus lupulus
Humulus lupulus
Il luppolo è una specie a distribuzione eurasiatico-nordamericana presente in tutte le regioni d’Italia. Originario di boschi alluvionali periodicamente inondati, si è trasferito in siti ruderali su suoli limoso-argillosi freschi e piuttosto profondi, ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1.200 metri circa. I fiori, sia femminili che maschili, sono utilizzati nel processo della produzione della birra, a cui il luppolo conferisce il tipico aroma. I getti giovani vengono utilizzati come gli asparagi per condire risotti e frittate. Il nome generico deriva da quello altogermanico della pianta (Humel), utilizzata per la produzione della birra; quello specifico è di significato incerto. Forma biologica: fanerofita lianosa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.
-
 Kosteletzkia pentacarpos
Kosteletzkia pentacarpos
E’ una pianta erbacea perenne che può arrivare a 2 metri di altezza, ma in genere rimane sugli 80-120 cm. Il fusto è cavo, molto ramificato in genere, coperto da peli a stella-ovate a ovate, le foglie con 3-5 lobi. Fiori numerosi, con petali roseo- violetti, raramente bianchi, frutti a capsula pelosa suddivisa in 5 settori contenenti ciascuno un seme. I semi possono conservare la fertilità anche per 20 anni, ma una serie di agenti patogeni possono ridurne drasticamente il numero.
E’ una specie alofila, cioè che sopporta alte concentrazioni di sale nel terreno, che vive nelle zone di retroduna. Il suo areale è molto ampio e include il Nord America e molte regioni mediterranee (Italia, Spagna, Francia), ma in Europa è fortemente ridotta a causa della pressione antropica e attualmente ridotto a singole popolazioni isolate fra loro, per cui è soggetta a protezione a livello internazionale ((Direttiva Habitat 92/43/UE). Un tempo in Italia era presente in diverse regioni da cui è scomparsa (Toscana, Lazio, Campania e Puglia) e ad oggi è presente solo in Veneto ed Emilia Romagna.
Il genere è dedicato a Kosteletzky, professore di Botanica Medica a Praga; il nome della specie deriva dal greco "pénte" cinque e "carpόs" frutto, in riferimento alla capsula con 5 loculi.
Nela Lista Rossa del Veneto le viene attribuito un livello di rischio “CR”, cioè gravemente minacciata di estinzione.
-
 Matricaria chamomilla
Matricaria chamomilla
La camomilla, forse originaria dell'Asia sud-orientale e da noi introdotta in epoca pre-romana a seguito dell’espandersi delle colture (archeofita), è una pianta annua oggi divenuta subcosmopolita presente in tutte le regioni d’Italia. Cresce in vegetazioni ruderali o arvensi, spesso come infestante delle colture di cereali, negli orti o lungo le strade, presso le case o nelle discariche, su suoli limoso-argillosi poveri in calcio, da neutri a subacidi, al di sotto della fascia montana superiore. La pianta contiene diversi principi attivi tra cui il camazulene, che ne giustificano l'uso medicinale. Il nome generico, dal latino 'matrix' (utero) allude all'uso contro i dolori mestruali o post-partum, il nome specifico risale invece al greco classico: il termine 'chamaemelon', citato già da Plinio, indicava una pianta bassa ('chamai') con odore di mela, mentre il termine latinizzato 'chamomilla' appare in edizioni di Dioscoride risalenti all'alto Medioevo. Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.
-
 Parietaria officinalis
Parietaria officinalis
L’erba vetriola comune è una specie dell’Europa centro-meridionale presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Calabria. Cresce in vegetazioni disturbate quali orli di boscaglie e siepi, a volte alla base di muri in situazioni piuttosto ombreggiate, su suoli argillosi piuttosto freschi e ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 900 metri circa. La pianta ha proprietà diuretiche, ma il polline è fortemente allergenico; le giovani foglie lessate venivano consumate come gli spinaci. Il nome generico si riferisce al fatto che molte specie crescono su muri; il nome specifico deriva dal latino 'officina' (officina, farmacia) e fa riferimento all’uso a scopo medicinale. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-ottobre.
-
 Phoenix dactylifera
Phoenix dactylifera
La palma da datteri è nota sin dall'antichità tra gli egizi, i cartaginesi, i greci, i romani e i berberi per i frutti eduli. Il tronco, più slanciato di quello della congenere Phoenix canariensis, può essere alto fino a 30 metri, ma di solito non supera i 15-20 metri. A causa dell'antichità delle coltivazioni (era già coltivata nel 4000 a.C. a Babilonia), l’areale originario non può essere determinato con certezza ma probabilmente comprendeva l'Africa settentrionale e forse l'Asia sudoccidentale. Oggi è coltivata in tutto il Maghreb, in Egitto, Arabia, nel Golfo Persico, nelle Canarie, nella zona mediterranea settentrionale e nel sud degli Stati Uniti. In Sicilia la palma da datteri è diffusissima come pianta ornamentale (ad esempio nei giardini di Palermo), ma non è sfruttata o coltivata a scopi commerciali. Le cultivar più diffuse sono 'Medjool', 'Deklet noor', 'Ameri', 'Deri', 'Halawi' e 'Zahidi', 'Berhi', 'Hiann'. Tra le varietà di dattero c'è quella definita "da amido", dalla quale si ricava il cosiddetto "pane del deserto", che rappresenta uno degli alimenti fondamentali dei beduini. Uno dei più temibili parassiti di questa pianta è il coleottero Rhynchophorus ferrugineus, noto come punteruolo rosso delle palme. Si tratta di un coleottero curculionide originario dell'Asia, propagatosi in Medio Oriente negli anni Ottanta e successivamente a tutto il bacino del Mar Mediterraneo, rivelatosi resistente a tutti i mezzi di controllo convenzionali. Il nome generico, già citato da Teofrasto, significa ‘fenicio’ perché sarebbero stati proprio i fenici a far conoscere queste piante ai greci; il nome specifico è composto da 'dactylus' (dattero, dal greco 'dactylos'), e 'fero' (io porto). Forma biologica: fanerofita scaposa.
-
 Cordyline australis
Cordyline australis
L'albero-cavolo, come viene chiamato nell’area di origine, è la più alta delle cinque specie di Cordyline native della Nuova Zelanda. La specie è diffusa da Capo Nord alla parte meridionale della South Island, dove diventa sempre meno comune, raggiungendo il limite meridionale a Sandy Point vicino Oreti Beach. In natura si comporta da specie pioniera che necessita di spazi aperti. L'albero era ben noto ai maori prima della sua descrizione scientifica: ogni tribù aveva nomi diversi per l'albero a seconda degli usi locali; il più usato, ‘Ti Kouka’, si riferisce all'uso delle giovani foglie come cibo. I fusti e rizomi carnosi di sono ricchi di zuccheri naturali e venivano cotti al vapore per produrre un alimento ricco di carboidrati utilizzato anche per dolcificare altri alimenti. Il ciuffo apicale di foglie giovani, simile a un cuore di carciofo, è commestibile da cotto. Una fibra dura e resistente alla salsedine viene ottenuta dalle foglie è stato estratto dalle foglie. La specie, introdotta in Gran Bretagna nel 1823, è oggi ampiamente usata a scopo ornamentale nelle parti più calde d’Europa, con diverse cultivar che differiscono soprattutto nella colorazione delle foglie. Il nome generico deriva dal greco ‘kordyle (clava), in riferimento alle parti ipogee ingrossate, quello specifico si riferisce alla provenienza dall’emisfero australe. Forma biologica: fanerofita scaposa. Syn.: Dracaena australis G. Forst.